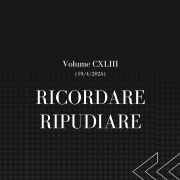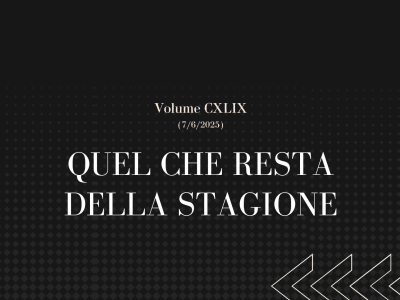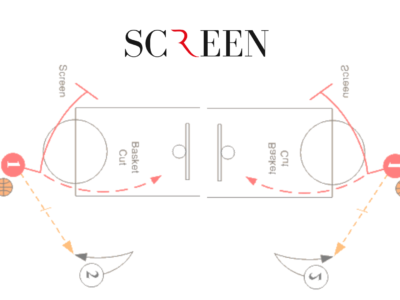di Guglielmo De Feis
In uno scenario calcistico ipotetico – oggi teoricamente verosimile e distopico, almeno secondo la prospettiva interista – la squadra di Simone Inzaghi potrebbe terminare la sua stagione senza alcun titolo vinto. A quel punto, la percezione generale – e non solo da parte dei tifosi interisti – sarebbe quella di un’annata disastrosa e fallimentare, magari perfino considerata inferiore a quella della squadra rivale cittadina, il Milan, che potrebbe invece terminarla con la vittoria di due trofei, qualora alla Supercoppa di gennaio dovesse abbinare anche la Coppa Italia a maggio.
In pratica, ricadendo in una paradossale inversione logica, si conferirebbe importanza sostanziale e oggettiva ai due trofei meno importanti (Supercoppa e Coppa Italia) per ricavarne un’intima e soggettiva percezione di felicità, nel paragone con chi non fosse riuscito a vincere i due più importanti (Scudetto e Champions League).
Eppure non possono esservi dubbi sul fatto che, a prescindere dai risultati finali in Campionato, Champions League e Coppa Italia delle due squadre, la stagione dell’Inter – ben giocata, a tratti entusiasmante e con molte vittorie di prestigio – sia da considerarsi nettamente migliore, sul piano sportivo, rispetto a quella altalenante e tribolata del Milan.
In un’epoca nella quale lo sport professionistico richiede enormi investimenti economici e sostanziosi interventi finanziari, da parte delle proprietà, anche i tifosi si sono abituati a ragionare in termini di bilanci commerciali, considerando le sconfitte come un deficit e attribuendo alle vittorie il valore di un surplus della loro squadra/stato.
Che il calcio sia un gioco a somma zero non vi sono dubbi. Se una squadra vince, l’altra perde e anche il pareggio non produce utilità ulteriori ma, al limite, dispersione di valore per entrambe le squadre che si dividono due punti, invece dei tre disponibili per la vincente.
Nel commercio internazionale, invece, è controverso che ci si trovi in un “gioco” a somma zero.
La visione del commercio internazionale dell’amministrazione Trump è ultra competitiva: se qualche Stato è in surplus, inevitabilmente qualche altro deve essere in deficit.
Secondo molti economisti, questa visione è – nella sua semplificazione eccessiva – erronea. Infatti se tutte le nazioni volessero esclusivamente perseguire il surplus, il commercio sarebbe paralizzato non essendo possibile, nella realtà e nella logica, che ciò avvenga.
La teoria del vantaggio comparato dell’economista inglese David Ricardo – sviluppata all’inizio del diciannovesimo secolo – sostiene l’esistenza di un valore ottenuto, anche per chi non ottiene un surplus. In questo modo, lo scambio commerciale non sarebbe un gioco a somma zero, i surplus non consisterebbero in vittorie e – men che meno – i deficit sarebbero delle sconfitte.
Per semplificare al massimo la teoria di Ricardo, senza dover affrontare con difficoltà il suo esempio su Portogallo, Inghilterra, vino e tessuti: chi va al bar a prendere un caffè si ritiene soddisfatto (qualora il caffè sia davvero buono) anche se è in deficit nel confronto col surplus del barista.
Se il bilancio commerciale matematico è effettivamente a somma zero (per ogni dollaro di surplus ve ne è uno di deficit) non così può dirsi del commercio internazionale in sé, in cui gli scambi commerciali possono generare valore per entrambe le parti.
Per lo stesso motivo, il bilancio calcistico – che considerasse vittorie e sconfitte, trofei vinti o mancati, semplicemente in termini di surplus e deficit – escluderebbe la valutazione della soddisfazione (per i tifosi) creata con la partecipazione, ad alto livello competitivo, della propria squadra, in tutte le partite giocate.
Il protezionismo dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti persegue l’utopia della vittoria commerciale ai danni degli altri Stati, rifiutando l’idea che esista un vantaggio comparato, consistente nel benessere economico per entrambe le parti coinvolte in uno scambio.
Se i tifosi continuano a ragionare in termini di bilanci commerciali, escludono dalle loro valutazioni tutta la sfera legata all’emotività e alla passione. Senza accorgersene, applicano dei virtuali dazi doganali alla loro soddisfazione di vedere, con partecipazione e trasporto, le partite della loro squadra, riconoscendole – solo a posteriori – i deficit e i surplus di sconfitte e vittorie, come se il “vantaggio comparato”, ricavato in una stagione di emozionanti partite viste, non valesse più nulla, disperso in sede di bilancio finale.
Nel calcio si è per molti anni camuffata come filosofia (il bel gioco fine a sé stesso di molti allenatori) quella che non era altro che una semplice ricerca di alibi per la sconfitta, facendo – al contempo – intendere che fosse quasi immorale scendere in campo con il fine dichiarato della vittoria. Sarebbe assurdo che adesso si cercasse di far passare per “fallito” chi invece ha lottato grandiosamente su tutti i fronti per l’intera stagione, senza far mistero che la vittoria fosse il suo obiettivo.
Il dileggio per lo sconfitto eccellente è oggi nel calcio italiano il punto di incontro tra lo sfogo del malanimo invidioso dei tifosi e la gioia per le disgrazie altrui (schadenfreude) delle persone. Si finge di voler punire, con la critica pungente, la hybris di chi cercava la vittoria – senza accontentarsi di una partecipazione “ben giocata – mentre in realtà si sfoga, con la derisione becera, la propria frustrazione per la bravura degli altri.
La sportività – è bene ricordarlo a chiare lettere – non consiste nel non voler perseguire la vittoria, ma nell’accettarla dopo aver cercato in tutti modi leali di ottenerla.
Leggi tutte le puntate di Cultural Intelligence
Guglielmo De Feis è docente di Cultural Intelligence al Settore Tecnico di Coverciano (nei corsi Master Uefa Pro, Direttore Sportivo, Preparatori Atletici, Osservatori) e al Coni (al corso per Team Manager).
La Cultural Intelligence è la capacità di relazionarsi e lavorare efficacemente negli ambiti interculturali e multiculturali. Psicologia individuale, sociologia antropologica, comunicazione cross culturale e interculturale sono tutte discipline direttamente dipendenti dalla Cultural Intelligence (C.Q.).