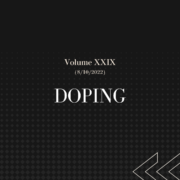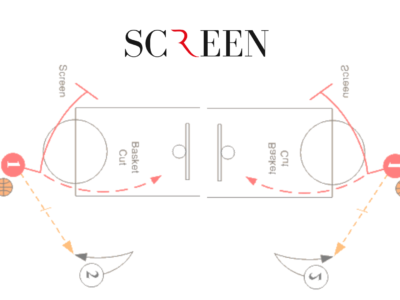di Nicola Sbetti
L’imminente Mondiale in Qatar e l’assegnazione dei Giochi asiatici invernali del 2029 all’Arabia Saudita hanno di nuovo portato in auge un’espressione che, negli ultimi anni, sembra essere molto in voga: sportswashing. Sul sito di Amnesty International viene definita: «Una strategia usata da stati o governi che sfruttano lo sport per rendere moderna la propria immagine e far distogliere lo sguardo dalla pessima situazione dei diritti umani nel proprio paese. Può avvenire tramite l’acquisto di squadre sportive, organizzazione di eventi o sponsorizzazione degli stessi». Rebecca Vincent, l’attivista di Reporters sans frontières che ha coniato il termine, intervistata nel libro di Coluccia-Giustini Calcio di Stato, definisce sportswashing : «Utilizzare lo sport per ripulirsi l’immagine e distogliere l’attenzione da altri problemi ben più gravi, come la sistematica violazione dei diritti umani per ragioni politiche, religiose, etniche o di genere». Il Guardian ha ipotizzato che il 2022 possa essere l’anno dello “sportswashing” data la concomitanza temporale delle Olimpiadi invernali di Pechino, il Mondiale di calcio maschile in Qatar e l’attivismo in campo sportivo dell’Arabia Saudita.
Come tanti altri anglicismi, questo neologismo nel nostro paese ha avuto un immediato successo ed è stato adottato non soltanto dagli attivisti per i diritti umani, ma anche dai mass media e più in generale dai commentatori sportivi. Si tratta di un’espressione sicuramente affascinante ed efficace sul piano narrativo, che però rischia di banalizzare un fenomeno complesso come quello dell’uso politico dello sport in un contesto internazionale.
Innanzitutto, quello che oggi viene tacciato di essere sportswashing, non è un fenomeno nuovo. Esiste da quando lo sport si è strutturato in competizioni internazionali. Lo sport, del resto, è uno dei molteplici terreni di scontro della politica internazionale; un campo di battaglia pacifico ma non neutrale che viene politicizzato tanto dai regimi autoritari quanto dalle democrazie. Certo Adolf Hitler ha sfruttato le Olimpiadi di Berlino del 1936 per associarsi ai sedicenti valori positivi dello sport e rassicurare (ma forse sarebbe meglio dire illudere) le cancellerie e le opinioni pubbliche europee e statunitensi sul fatto che non fosse intenzione del Terzo Reich perseguire una politica estera ultra-aggressiva. Allo stesso modo però Nelson Mandela, ha strumentalizzato con grande efficacia una serie di eventi sportivi organizzati in Sudafrica come il Mondiale di rugby del 1995, la Coppa d’Africa di calcio del 1996 o il Mondiale di cricket del 2003, per promuovere internamente i processi di riconciliazione ed esternamente l’immagine del Sudafrica come una moderna “Rainbow nation”. Con le lenti del presente, però, sebbene in entrambi i casi vi sia un uso dello sport a fini politici, si parlerebbe di sportswashing solo per la Germania nazista e non per il democratico Sudafrica.
Infatti, e qui introduciamo un secondo elemento, non si tratta di un termine scientifico, bensì di un’espressione che viene usata con un chiaro intento politico, ovvero: biasimare le strumentalizzazioni dello sport da parte di un paese di cui non si apprezza la condotta morale. È funzionale a tracciare una linea di separazione fra l’uso politico dello sport che fanno i paesi democratici e quelli autoritari: i primi non fanno sportswashing i secondi si! Non è quindi un termine che serve a spiegare l’uso propagandistico dello sport o, se vogliamo restare in tema di anglicismi, l’utilizzo dello sport come strumento di soft power. Serve piuttosto a condannare moralmente il paese non democratico e non rispettoso dei più basilari diritti umani che usa lo sport a fini politici, al di là del fatto che simili modalità vengano o meno adottate anche da paesi democratici.
Che differenza c’è fra andare ad inaugurare a Praga la stagione dell’NHL (il campionato nordamericano di hockey su ghiaccio) e giocare per la terza volta in cinque anni la Supercoppa italiana in Arabia Saudita? In entrambi i casi abbiamo una lega professionistica che per incrementare i propri profitti decide di accogliere la proposta economica di un altro paese interessato ad ospitare l’evento, ma solo il secondo viene definito sportswashing. Il motivo è da rintracciare nel diverso giudizio che chi utilizza questa espressione dà a una repubblica democratica membro dell’Unione europea rispetto a una monarchia assoluta islamica del Golfo. Anche le multiproprietà nel calcio non sono certo una prerogativa dei fondi sovrani delle monarchie del Golfo, basti pensare alla multinazionale austriaca Red Bull.
Per certi versi, poi, utilizzando questo termine si finisce implicitamente per promuove uno sguardo eccessivamente manicheo di un mondo diviso in Stati “buoni” legittimati ad organizzare eventi sportivi e stati “canaglia” indegni di questo onore. Invece non è tutto bianco o nero. Tralasciando il fatto che nel decennio successivo alla crisi del 2008, i paesi occidentali avevano parzialmente mollato il controllo sulla politica sportiva e pressoché smesso di voler organizzare grandi eventi sportivi internazionali che erano diventati così terreno di conquista per i cosiddetti “BRICS”, per le monarchie del golfo e per altri paesi emergenti, anche nel mondo dello sport non mancano le zone grigie. Non esistono, è banale dirlo, paesi che non violino i diritti umani, nemmeno quelli scandinavi, che pure sono all’avanguardia nella loro difesa. Pensiamo per esempio all’Italia, che dal G8 di Genova, alla cooperazione con la Libia sui migranti può vantare diversi scheletri nell’armadio. All’opposto il vincolo esterno rappresentato dai regolamenti delle istituzioni sportive internazionali, ma soprattutto la pressione politica e mediatica delle Ong e della società civile, impone sempre più spesso ai paesi accusati di fare “sportswashing” di elevare le proprie tutele e ridurre le discriminazioni se vogliono evitare che il loro investimento politico sullo sport si riveli controproducente.
Infine l’utilizzo di questo termine si rivela fortemente etnocentrico e risente non poco del complesso di superiorità anglosassone. Chi lo adotta tende infatti a porsi in una posizione di superiorità morale rispetto alla realtà che si vuole condannare per i suoi non abbastanza elevati standard democratici e umanitari.
Non usare l’espressione sportswashing, quindi, non significa sminuire l’importanza delle Ong che lavorano per la difesa dei diritti umani. Anzi, va dato atto che è proprio grazie alla loro azione se oggi, 13 ottobtre 2022, la FIFA ha aperto alla possibilità di istituire un fondo di compensazione per i lavoratori sfruttati, infortunati e deceduti nella costruzione degli stadi per il Mondiale di Qatar 2022. Decidere di non usarla non significa nemmeno rinunciare a condannare le gravi violazioni dei diritti umani da parte di paesi autoritari che investono nello sport nella speranza di migliorare la propria reputazione. È, innanzitutto, un modo per sfuggire all’ipocrisia tipicamente occidentale di chi si indigna dello sportwashing di paesi come Qatar e Arabia Saudita, salvo poi voltare la testa quando si tratta di comprare gas o commerciare armi. È, soprattutto, un modo per non semplificare eccessivamente né banalizzare l’uso dello sport a fini di politica internazionale che tanto i governi autoritari quanto quelli democratici possono decidere di portare avanti. È, inoltre, un modo per non limitarsi ad una condanna tranchant, ma piuttosto interrogarsi per quali altre ragioni, oltre a quella di cercare di migliorare la propria reputazione internazionale e distogliere l’attenzione da gravi violazioni dei diritti umani, paesi autoritari scelgono di investire nello sport. È, infine, un modo per chiedersi chi ha preferito rinnegare i sedicenti valori dello sport, troppo spesso sbandierati con fini poco nobili, e per quale motivo lo ha fatto? Del resto accanto ad un emiro o a un dittatore pronto a fare dello sportswashing c’è sempre qualcuno come Jérôme Valcke. Proprio in questi giorni, infatti, l’ex segretario della FIFA ai tempi di Blatter, già celebre per l’infelice uscita secondo cui a volte per organizzare un Mondiale fosse auspicabile meno democrazia, ha nuovamente espresso le sue idee senza e, intervistato da Le Monde sull’assegnazione ai Mondiali del 2022, ha candidamente ammesso: «Ci siamo detti “Il Qatar ha talmente tanti soldi, approfittiamone”».